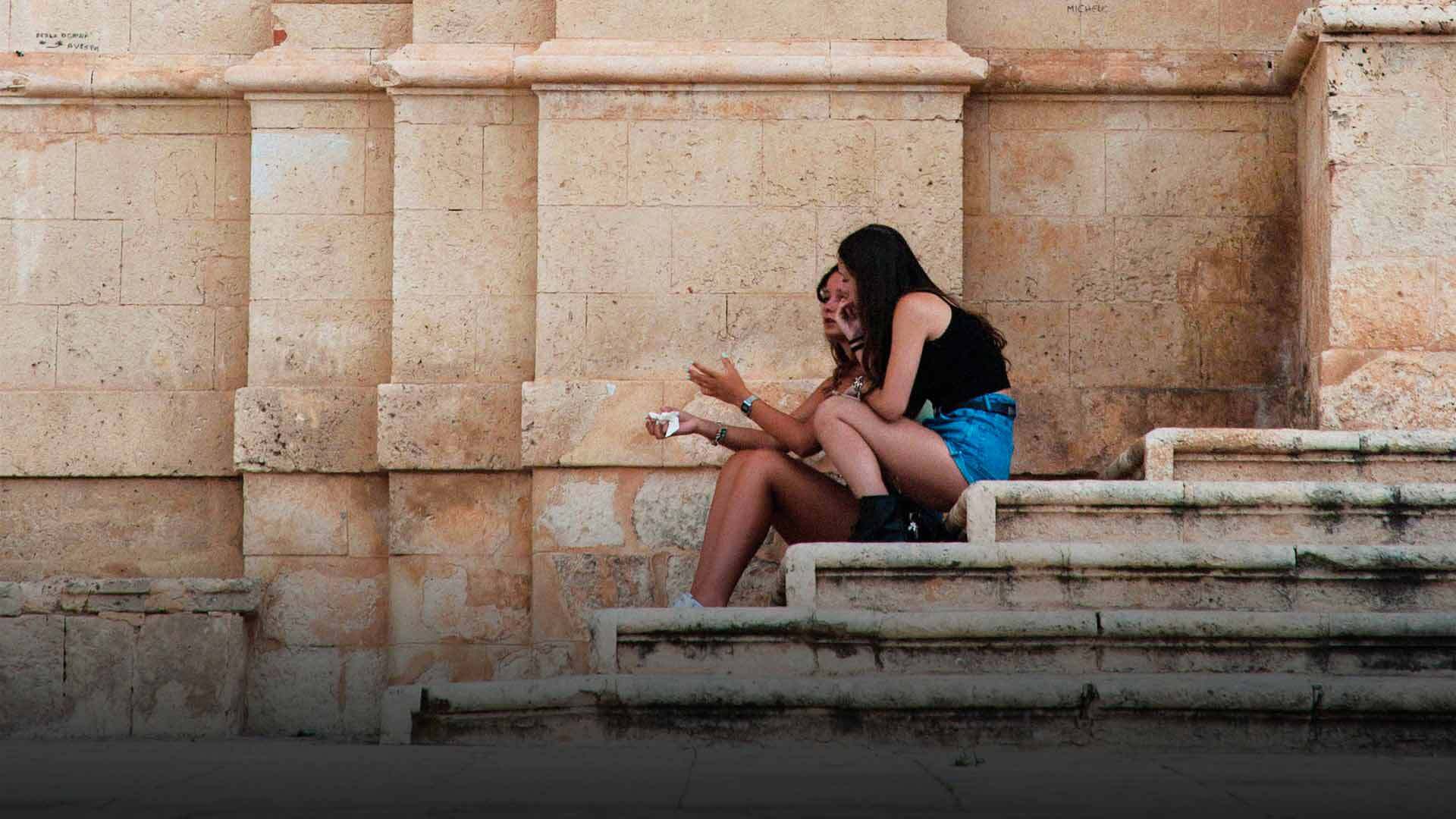giovani
La nostra attenzione dura al massimo 8 secondi
La nostra capacità di attenzione e di concentrazione è calata drasticamente negli ultimi vent’anni, alcuni studi parlano di una soglia minima di 8 secondi, meno di un pesce rosso. La causa si nasconde nel rapporto che abbiamo sviluppato con la connettività e con lo strumento che la incarna: lo smartphone. Anche quando è nella tasca, lontano dai nostri occhi e silenzioso, ci scopriamo a pensarci, forse a sfiorarlo con le dita. Sbloccarlo e scrollarne i social è la fonte di una scarica di dopamina alla quale rischiamo di diventare dipendenti. «Nella scala che va dalle caramelle al crack lo schermo è molto più vicino al crack» ha detto Chris Anderson, ex direttore di Wired USA. Insomma, per passare dall’Era dell’Acquario a quella del Pesce Rosso sembra sia bastato uno smartphone. Ne abbiamo parlato con la giornalista Lisa Iotti, che nel nuovo libro 8 secondi ha raccontato il suo viaggio alla scoperta dei problemi dell’iperconnessione, dalla dipendenza da smartphone al multitasking.
L’attenzione di un pesce rosso
Fu una ricerca della Microsoft Canada a misurare in 8 secondi l’attenzione media di una persona. Nello stesso periodo Google lanciò un algoritmo che ricavò su per giù la stessa cifra, 12 secondi. In realtà, però, lo studio più accreditato sull’argomento è quello di Gloria Mark, professoressa dell’Università della California, Irvine e «rockstar dell’antropologia digitale». La Mark ha seguito le persone nel luogo dove l’attenzione è, diciamo così, dovuta: l’ufficio, misurando il tempo massimo di concentrazione. 10 anni fa, quando nacque lo smartphone, era 3 minuti, 6 anni fa si era ridotto a 1.15 minuti, oggi è sceso a 40 secondi. «Gli 8 secondi del pesce rosso di cui parlava la ricerca di Microsoft forse erano una provocazione, ma i 40 secondi cronometrati dal team della professoressa Mark sono reali» scrive Lisa Iotti che, poi, ci spiega al telefono che non è solo un problema di quei pochi momenti in cui passiamo dal monitor al telefono: «Sono istanti di distrazione, però poi ci vogliono 25 minuti per riprendere la concentrazione. Questa cosa ti da scariche di dopamina perché ormai il tuo cervello ne ha bisogno proprio come una droga, ma dall’altro rilascia cortisolo e genera stress. Ha un impatto fortissimo sulla sindrome da affaticamento». Il burnout è ormai uno dei mali del nostro secolo. Insomma siamo attratti dallo smartphone e in un certo senso ne finiamo imprigionati come in un loop: «Loop, laccio, cappio è un termine metaforicamente interessante» continua Lisa Iotti «perché tu entri in questi strumenti in cui nulla è casuale: tutto quello che fai lo fai perché qualcuno lo ha progettato». I social network hanno, in effetti, un’architettura studiata per tenerci connessi e farci tornare il più possibile, come ha mostrato l’ultimo documentario Netflix, The Social Dilemma. Ma c’è anche qualcosa di più profondo. In un certo senso siamo biologicamente programmati per essere distratti dalle notifiche. Il nostro cervello ama le novità ed è attirato dai suoni «quando eravamo primati» continua Lisa Iotti «e sentivamo un rumore, se non ci fossimo girati a controllare se era una foglia o un leone, ora non saremmo qui». Nel libro Gloria Mark però fa un passo oltre: «Siamo continuamente distratti da messaggi e notifiche, e quando non c’è nulla che ci interrompe, lo facciamo noi, perché ne abbiamo bisogno. Abbiamo dimostrato che mentre le persone sono al lavoro e stanno facendo qualcosa di importante improvvisamente si fermano, prendono in mano il telefono, e si mettono a chattare o a controllare i social. Non possono più farne a meno».
Lo smartphone è il nostro ciuccio
La neuroscienziata Maryanne Wolfe e lo psichiatra Laurent Karila hanno efficacemente descritto il nostro modo di vivere il rapporto con Internet e lo smartphone. Per la Wolfe è un ciuccio di cui non possiamo fare a meno, per Laurent Karila invece un doudou: «Che cos’è un doudou per i bambini?» spiega nel libro di Lisa Iotti «un orsetto, un peluche, un pezzo di tela da toccare, da accarezzare. È qualcosa che li calma, li tranquillizza, che li fa dormire più sereni. Gli smartphone per noi sono la stessa cosa, a qualunque età. E infatti qual è la prima cosa che fanno gli adulti quando si svegliano durante la notte? Prendono in mano il telefonino, lo guardano, ci digitano e poi si rimettono a dormire». Un’abitudine che sembra accomunare il 37% degli italiani. Il risultato è che un terzo delle nostre giornate è speso davanti allo schermo, circa 6 ore, e che, come spiega un articolo dell’Educational di Harvard: «Ogni notifica, che si tratti di un messaggio di testo, un “mi piace” su Instagram, o una notifica di Facebook, è potenzialmente uno stimolo sociale positivo e l’“iperafflusso” di dopamina a cui il cervello viene esposto quando siamo bombardati da uno smartphone può essere equiparato, anche se non in modo così potente, a un tiro di cocaina. Da qui la possibilità che, come per le droghe sintetiche, si instaurino vere e proprie dipendenze, soprattutto in soggetti geneticamente e/o psicologicamente vulnerabili. Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram sfruttano gli stessi circuiti neurali usati dalle droghe e dalle slot machine per indurci a stare il più tempo possibile sulle loro bacheche». E poi, va considerata la tendenza al multitasking.
Intrappolati dal multitasking
Internet è la più grande occasione che l’uomo abbia avuto per raccogliere e comunicare la conoscenza. Nella storia della nostra specie non è mai esistita una capacità di accesso allo scibile umano così vasta e completa come il web. Ma questa ampiezza di raggio ci ha spinto sulla strada del multitasking. In un certo senso abbiamo modellato il nostro modo di lavorare e di fruire del sapere sul sistema a finestre di Windows, del Mac, dell’IPhone. Nicholas Carr nel suo famoso libro Internet ci rende stupidi?, racconta proprio il momento in cui fu creato quel sistema: «Noi lo diamo per scontato» ci racconta Lisa Iotti «ma non è sempre stato così. Carr racconta che quando si sono messi a studiare un nuovo sistema operativo ed è venuto fuori il sistema a finestre, come Windows, è nato un dibattito: perché devo essere distratto da una mail mentre sto lavorando a un documento importante? Poi ha vinto quel sistema ed è diventato il nostro modo di lavorare e di pensare. Ma noi non siamo multitasker, tutta una serie di studi lo conferma». Come quello di Charron e Koechlin che, usando le risonanze magnetiche funzionali, hanno dimostrato come il nostro cervello non riesca a seguire più cose contemporaneamente: «Noi switchiamo, velocissimi» da una cosa all’altra. «Questo switchare ha un costo energetico» ed effetti deleteri che creano stress e abbassano le prestazioni, come dimostra anche una ricerca dell’istituto tedesco Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Ma non solo, ci dice Lisa Iotti: «la cosa che mi ha molto colpito in un libro di Daniel Levitin», il famoso The Organized Mind «è che il nostro cervello è fatto per processare al massimo 120 bit, ma non per dare delle priorità. Se noi gli buttiamo dentro di tutto lui lo processa, non ha una cartella spam. Quindi quando poi arriva una cosa importante non hai più l’energia mentale per affrontarla». Un esperimento di Stanford ha dimostrato che su 260 studenti multitasking le prestazioni di quelli più abituati a questa pratica (heavy multitasker) erano le peggiori «più erano multitasker e meno erano capaci di filtrare informazioni, quello che è essenziale e quello che non lo è». Il multitasking può essere un’attitudine anche nell’assunzione di informazioni, nel saltare da un link all’altro compulsivamente «E secondo me è quello che è successo a tutti noi in questi mesi di lockdown».
Levitin e l’enigma della penna
Il lockdown della pandemia è stato accompagnato dal fenomeno dell’infodemia che ha amplificato un problema già esistente: l’incapacità di valutare la rilevanza di un’informazione rispetto ad altre e orientarsi nel mare magnum delle news in rete. Lisa Iotti racconta: «Il libro The Organized Mind di Levitin inizia con la storia di una sua allieva che viene dalla Romania di Ceausescu, in cui non aveva niente: una sola penna, un solo quaderno. Questa ragazza racconta al prof. Levitin che non riesce a scegliere una penna: “Entro in un negozio in America e mi trovo davanti a decine di penne, devo mettermi lì e decidere quale penna comprare” e quello è stress mentale». Lo stesso le accadeva entrando in un supermercato. L’iperscelta e l’ansia che l’accompagna sono due aspetti tipici di quest’epoca, e, in casi estremi, hanno dato origine anche a fenomeni sociali complessi come quello degli hikikomori, legato anche ad altre problematiche, ma che è connesso a doppio filo con le nuove dipendenze, come ci ha spiegato la dott.ssa Valentina di Liberto, fondatrice del centro Hikikomori di Milano. Ma in questo oceano sterminato di notizie, siti, voci e dati come orientarsi? Gli algoritmi, infatti, sono stati costruiti per soddisfarci, non per informarci e le due cose non sempre coincidono. Il rischio, quindi, è che, travolti dalla marea crescente di informazioni, i nostri bias e pregiudizi di conferma diventino il timone della navigazione su internet. Con effetti terribili soprattutto sui più giovani.
Un’educazione umanistica al digitale
Internet e gli smartphone sono qui per restare. Le esortazioni luddite di alcuni filosofi a rinunciare a entrambi questi traguardi tecnologici suonano irrealistiche. Quindi come possiamo affrontare la rivoluzione digitale ed evitarne le trappole? Il Professor Damiano Canale, dell’Università Bocconi, pensa che la via giusta sia quella umanistica. «Per questo nel tempio degli studi economici e giuridici, ha istituito dal settembre 2018 un nuovo corso: Pensiero critico, obbligatorio per tutti gli iscritti del primo anno (duemila studenti)» racconta Lisa Iotti in 8 secondi, riportando le parole di Canale: «I ragazzi arrivano all’università che non hanno più familiarità con il ragionamento in senso lato, non sanno più argomentare una tesi e questo ha a che fare con il tempo che passano online. Hanno un’idea in testa ma non riescono a strutturarla perché non conoscono più le regole della logica, e noi lo vediamo benissimo nelle tesi scritte o agli orali: quando si ragiona si possono fare degli errori, certo, ma le persone in genere se ne accorgono; questi ragazzi no, non ne hanno consapevolezza. E questo perché non sono più abituati, la loro capacità di pensare in modo critico si è indebolita, non riescono più a distinguere quello che è rilevante da quello che non lo è, non sanno più filtrare» e conclude «Non hanno gli strumenti perché oggi in rete premiano solo la frase a effetto, l’aggressività, la violenza verbale, le urla: sono queste le modalità. Abbiamo voluto questo corso obbligatorio per aiutare gli studenti a far funzionare la testa, che sembra disattivata dall’ambiente in cui vivono». Dopo aver parlato di algoritmi, social media, smartphone, multitasking ci troviamo davanti a una svolta inaspettata, a una domanda che cambia la nostra prospettiva: che proprio la vecchia umanistica possa risolvere il difficile rapporto tra uomo e digitale? Nel frattempo possiamo osservare le semplici regole esposte da Laurent Karila in 8 secondi: «Non dare i dispositivi in mano ai bambini come fossero babysitter; non guardare gli schermi di notte; non tirare fuori i cellulari ogni volta che ci si annoia; non usarli a tavola; non essere sempre reperibili; non andare al bar o all’aperitivo e stare tutto il tempo al cellulare». Sembrerebbe semplice.
Segui VD su Instagram.