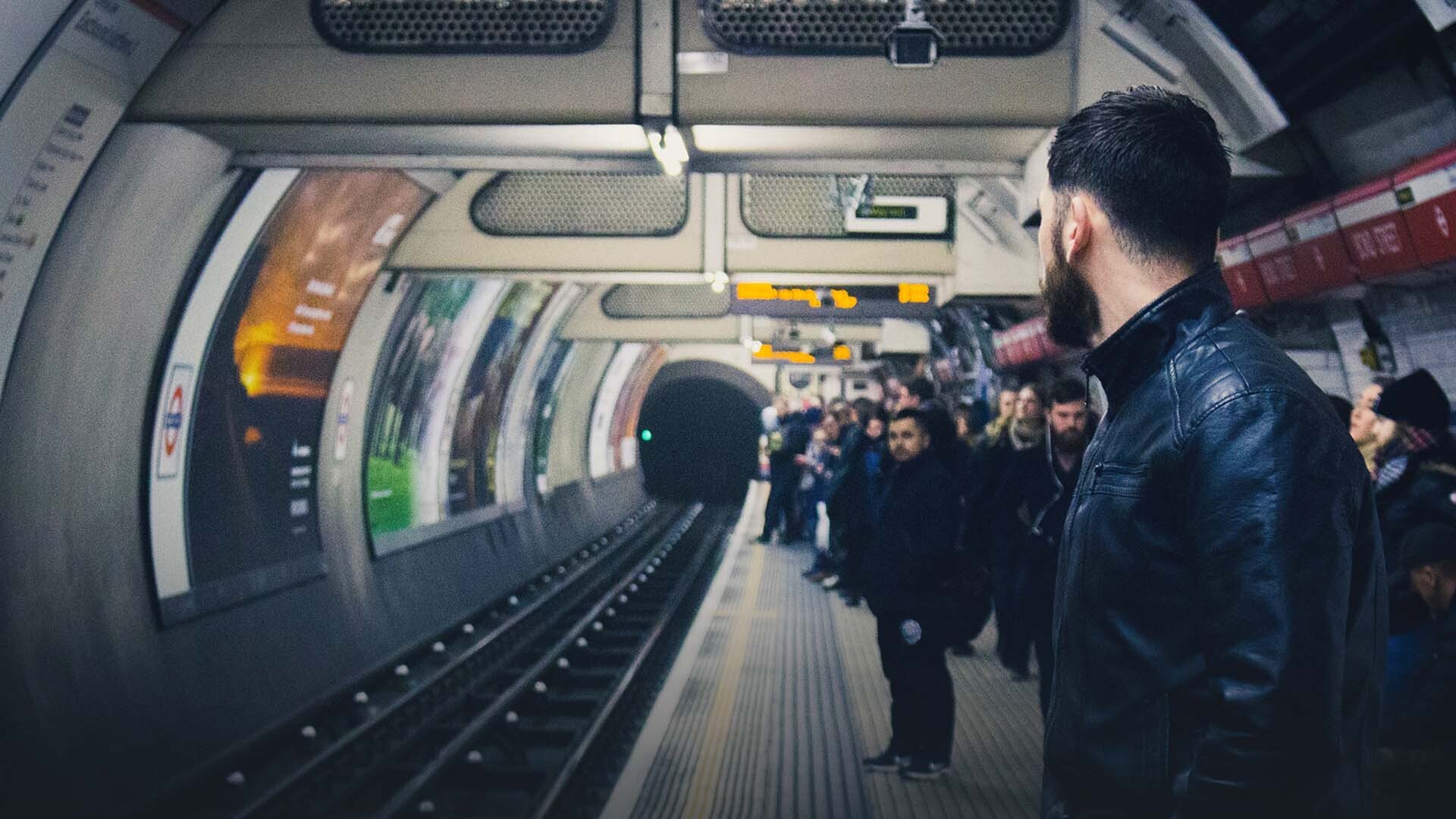lavoro
Il lavoro è un amore non corrisposto
Da anni circola sui social network, decorata in modo improbabile, la massima «Fai ciò che ami e non lavorerai mai un giorno della tua vita»: attribuita a Confucio, la frase è entrata nel prontuario di tutti, o quasi. La si può sfoderare e cercare di far bella figura in una conversazione con persone che non si incontrano da decenni, fingendosi interessati ai loro mestieri, al loro percorso professionale. Il concetto confuciano è questo: se il lavoro che fai è quello che hai sempre desiderato, o addirittura se la passione della tua vita è diventata la tua fonte di sostentamento, non hai da lamentarti. Non dovresti sentire stress o fatica sul luogo di lavoro, non dovresti essere rigido sul rispetto degli orari (meglio qualche ora in più) e neanche avere troppe remore sulla paga. Sarà anche esigua ma in fondo, che vuoi? «Fai quello che ti piace». Concetti che stridono con i dati appena pubblicati, al termine di un lungo studio condotto dall'OMS e dall'OIL: secondo questa indagine mezzo miliardo di lavoratori viene esposto a troppe ore di lavoro, più di 55 a settimana. Un eccesso che ha causato circa 700mila morti per ischemia e infarti, riconducibili allo stress da lavoro, e 23 milioni di anni persi in salute dai lavoratori.
Un esercito di sfruttati
Il "lavorismo" è raccontato molto bene da Sarah Jaffe, giornalista americana, nel suo libro Work won’t love you back (Il lavoro non ricambierà il tuo amore), uscito a gennaio per The Bold Type, casa editrice americana del gruppo Hachette. Il libro, non ancora tradotto in italiano, è stato molto apprezzato negli Stati Uniti. Sarah Jaffe perlustra il mondo del lavoro andando al cuore di ogni mestiere, raccontandone le ipocrisie attraverso lunghi reportage. Sono dieci i focus, intense interviste ai lavoratori: dallo stagista non retribuito all’insegnante sull’orlo di una crisi di nervi, dal dipendente di una no-profit al magazziniere Amazon, fino all’atleta professionista. Emerge, chiara, la tirannia del lavoro, che non lascia spazio e tempo per nulla. «Come la devozione ai nostri lavori ci ha resi sfruttati, esauriti e soli» è l’emblematico sottotitolo del libro. VD ha intervistato Sarah Jaffe.
VD: Le prime esperienze lavorative, soprattutto per i giovani del Sud Italia, sono complicate. Molto spesso sottopagati, devono accettare passivamente l’idea di una non meglio determinata “gavetta” che sarà solo doveri senza diritti. Come si eradica questa mentalità nei datori? Ritieni, inoltre, che ci sia bisogno di un’educazione al lavoro già a scuola, così da formare cittadini e lavoratori consapevoli?
SJ: Questo è un ottimo punto. Di questo parlo quando tratto la questione dei tirocini non retribuiti, quando le persone sentono di doversi “guadagnare” il loro lavoro e diventa difficile ribadire i propri diritti. E’ un problema che non si risolve semplicemente imparando a dire ‘No’. Molte volte, se dici ‘No’ al tuo capo, ti ritrovi senza lavoro. Certo, educare le giovani generazioni riguardo i propri diritti sul luogo di lavoro sarebbe un’ottima idea. Ho parlato con un lavoratore Amazon del Minnesota che ha detto questo: a scuola impari che hai il diritto di votare, ma non impari nulla sui tuoi diritti sul luogo di lavoro. La verità è che individualmente si può fare ben poco per rinsaldare questi diritti, ci vuole spirito d’unione sindacale e usare la forza dei numeri per spingere.
VD: Nel tuo libro i protagonisti arrivano a chiedersi che senso abbia lavorare così duramente quando non resta tempo e non restano energie per niente altro? Qual è la risposta che si danno?
SJ: Esatto, spesso non sembra che ci sia un senso. Ecco perché tutti i lavoratori dei quali parlo si impegnano per cambiare i loro luoghi di lavoro. I programmatori di videogiochi si sono organizzati per combattere contro l’enorme monte ore di straordinari (che nell’industria chiamano crunch), i lavoratori domestici si sono organizzati per avere tempo libero da spendere con le loro famiglie, i professori part-time per avere controllo sui programmi e tutti loro si sono organizzati per avere paghe più alte.
VD: Cosa sono le “tre speranze"?
SJ: Ne parlava l’artigiano socialista inglese William Morris. Le tre speranze rendono il lavoro piacevole: la speranza del riposo, la speranza del risultato e la speranza del piacere nel lavoro stesso. E penso che ancora siano valide. Abbiamo, certamente, ancora bisogno di riposo ed è una cosa alla quale costantemente pensiamo durante il lavoro, sperando di arrivarci. Sulla speranza del prodotto, e del risultato, ho riflettuto molto recentemente. Ho raccontato la battaglia dei dipendenti della Gimlet, una società che produce podcast, di proprietà del colosso Spotify. I dipendenti chiedono più controllo sulla loro proprietà intellettuale. Molte persone aspirano a essere “i boss di loro stessi” e questo credo sia anche il desiderio di controllare i risultati del proprio lavoro. Poi c’è la grande, complicata questione della speranza del piacere nel lavoro stesso. Che è molto più complicata della banale “fai ciò che ami”. Nel giornalismo, ad esempio, ho avuto incarichi grandiosi e incarichi terribili. Ho avuto lavori nel terziario dove ho creato ottimi con i miei colleghi e, per quanto non amassi fare la cameriera, quel lavoro non era male. Quindi: come possiamo rendere il lavoro meno detestabile, sia esso in un magazzino Amazon, in un ristorante o per una compagnia che produce videogames? Dipende da autonomia, potere e libertà. Quanto potere di cambiare le cose ho sul luogo di lavoro, se sono infelice? Morris era un creativo e un impiegato, e se all’inizio sosteneva che il lavoro fosse migliorabile e che il lavoro creativo fosse piacevole in sé, in seguito spiegò che non puoi avere un lavoro libero in un mondo capitalista.
VD: “Fai ciò che ami”, peraltro, è un’affermazione che finisce con l’indebolire la posizione del lavoratore nei confronti del suo capo.
SJ: Se pensi di dover essere riconoscente perché hai un lavoro eccitante e creativo, è difficile alzarsi e chiedere di più. E questo porta anche a una marea di lavori, nel mondo artistico, che sono fatti gratuitamente. Ma queste sono anche industrie nelle quali tante persone si arricchiscono in maniera eccessiva, e invece di essere vittime dell’idea che siamo fortunati ad avere il nostro lavoro, dovremmo chiederci quanto valore creiamo per il nostro capo.
VD: In Spagna stanno sperimentando una settimana lavorativa di quattro giorni, dal lunedì al giovedì. Cosa ne pensi?
SJ: Penso sia una gran cosa. La sfida è che per molte persone anche cinque giorni di lavoro non sono pagati abbastanza. Quindi, come combiniamo una settimana di lavoro più breve con condizioni migliori, così che le persone possano guadagnare abbastanza in quattro giorni per godersi davvero gli altri tre giorni della settimana? Come potrebbe funzionare per me, che sono freelance e non sono pagata a ora, ma a ingaggio?
VD: Cosa pensi del reddito universale?
SJ: Ci ho riflettuto a lungo. Le persone che lo chiedevano negli Stati Uniti erano le donne del movimento per i Diritti del Welfare, donne che puntavano al reddito di base come a un modo per risolvere i problemi del welfare punitivo che avevamo. Erano derise, guardate di traverso e stigmatizzate perché “pigre”. E per me è così divertente che nello stesso momento tutti insistano sull’amore per il proprio lavoro, che gli esseri umani debbano lavorare per trovare significato alla vita, e poi ci preoccupiamo perché – anche durante la pandemia - “se paghiamo qualcuno per stare a casa non lavorerà mai più”. Il reddito universale non sarà un palliativo, ma qualcosa che può dare alle persone la possibilità di sfuggire da un lavoro pericoloso e spiacevole, e quindi determinare un complessivo cambio di rotta: il lavoro che esiste dovrà migliorare, così i capi dovranno convincere i dipendenti a tornare al lavoro. Mi sembra un buon inizio. Le donne del movimento per i Diritti del Welfare sostenevano anche che un lavoro loro l’avevano già: a casa, crescendo i figli, dando assistenza agli anziani e occupandosi delle loro comunità. Un lavoro che meritava una ricompensa. Un reddito universale eliminerebbe gli stereotipi che si abbinano a chi usufruisce dei programmi welfare: scrocconi, pigri, parassitari. Peraltro negli Stati Uniti, con Biden, abbiamo appena imparato che, sì, in effetti il Governo può mandare assegni a tutti. Anche se sto ancora aspettando il mio.
VD: Quando un capo dice “siamo una famiglia”, cosa scatta o dovrebbe scattare nella testa di un lavoratore?
SJ: Molti lavoratori non hanno potere per dire nulla. Ma inviterei tutti a ricordare che la famiglia è un posto dove c’è tanto lavoro, e solitamente non è pagato e non è apprezzato. Pensateci: quando il vostro capo dice “siamo una famiglia” sta forse implicitamente dicendo che dovrete prendervi tante responsabilità senza essere ricompensati, e vi sta chiedendo sacrifici per amore?
VD: Qual è la storia, fra quelle che hai raccontato, che ti ha coinvolta di più?
SJ: Ho pensato molto ad Ann Marie Reinhart, la dipendente della catena di negozi di giocattoli Toys R Us, perché è stata contagiata dal Covid-19 ed è morta alcuni giorni dopo l’uscita del libro. Era una donna calorosa, generosa e piena d’amore, ed era in quella categoria di lavoratori a contatto con il pubblico che ha pagato il prezzo più alto durante la pandemia. Ero seduta nel salotto di Ann Marie, con le decorazioni natalizie, mentre mi mostrava le cicatrici causate da chi le aveva lanciato un giocattolo in fronte. Lei rideva, pensando di essere diventata una piantagrane dopo 30 anni di lavoro… Mi manca. Meritava una sorte migliore.
VD: Esiste un “capo ideale”?
SJ: Risposta secca: no. Risposta articolata: avevo un ottimo lavoro, per un anno circa l’ho avuto. Lavoravo per un piccolo show televisivo indipendente, per una donna che è ancora una mia grande amica. Non guadagnavamo molto, ma era un gruppo entusiasmante e facevamo un grande show. Ho imparato tanto. Ma c’era anche tanta pressione su tutti noi, perché cercavamo di produrre un programma televisivo con un budget ristretto, ed eravamo precari perché era un programma non sostenibile al livello in cui ci trovavamo. La lezione è che anche il miglior boss potenziale sta fronteggiando le pressioni del capitalismo, schiacciato tra gli investitori e i costi di produzione. Se sei un boss, però, ci sono cose che potresti migliorare per i tuoi dipendenti. Comincia a non metterti in mezzo se organizzano un sindacato, pagali in modo giusto, dai loro del tempo libero, ascolta le loro idee e non punirli ma fai del tuo meglio per trattarli come essere umani.
VD: Ti sei sentita “sfruttata, esausta e sola” scrivendo il tuo libro?
SJ: Un amico, scherzando, diceva che avremmo dovuto chiamare il tour virtuale di presentazioni del libro Sfruttati, esausti e soli: il tour, perché è così che mi sento, spesso, ultimamente. Soprattutto sola, perché fare presentazioni su Zoom è deprimente. Scrivere è un’attività solitaria e frustrante, molte volte. Ci sono parti di questo progetto in cui mi sono genuinamente divertita, e altre in cui volevo lanciare il computer dal ponte e andare ad allevare pecore. È lavoro, è pur sempre lavoro.
Segui VD su Instagram.