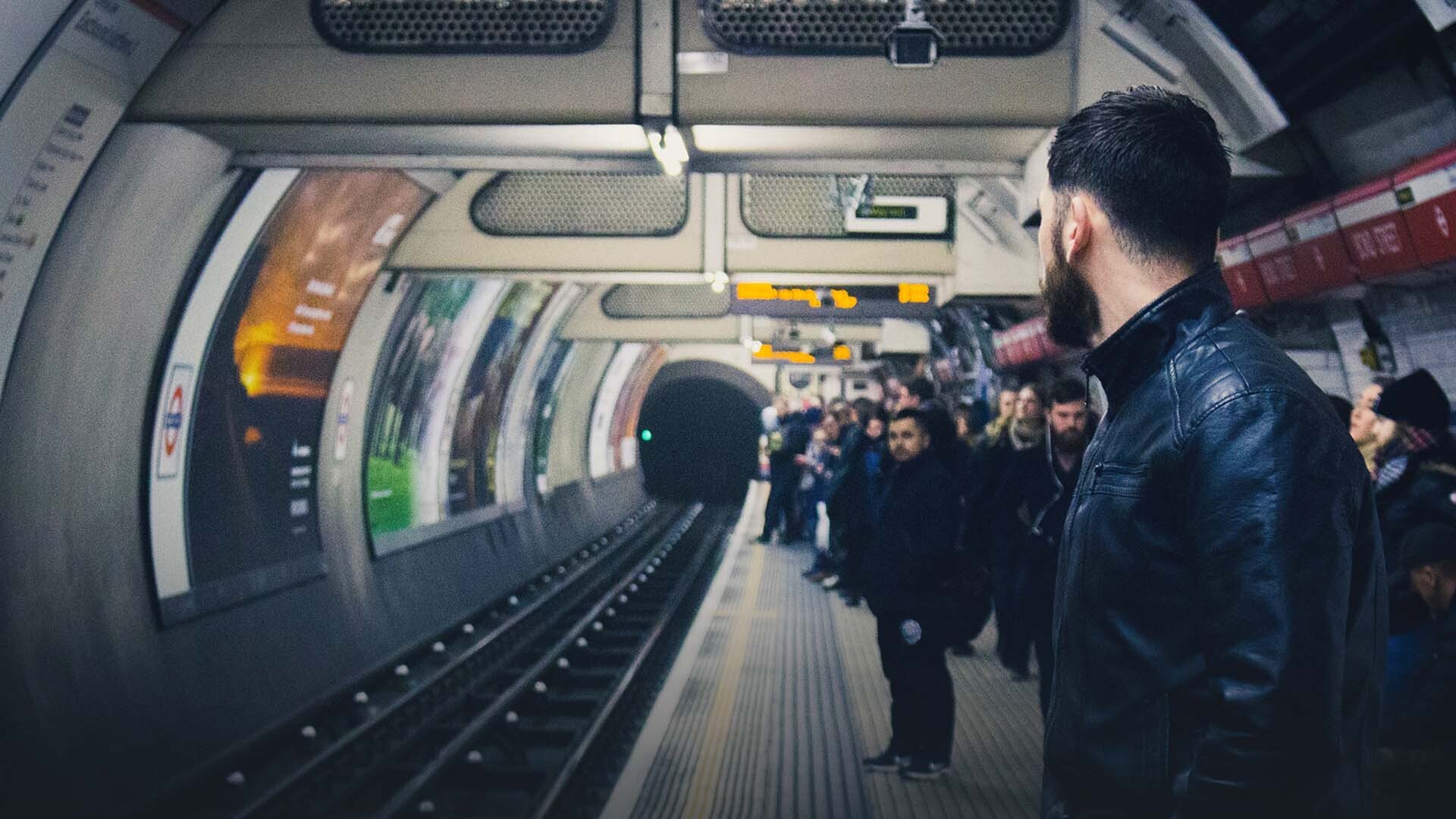lavoro
Turni massacranti e aggressioni: gli infermieri sono in fuga dai pronto soccorso
Era l’inizio della pandemia quando, stretti sui terrazzi di casa, battevamo le mani per infermieri e medici. Barbara, che fa l’infermiera da pochi anni racconta che, allo scoppio dell’emergenza, le persone portavano addirittura i dolci nei pronto soccorso. «Ora ci tirano gli schiaffi», dice a VD. L’eccitazione collettiva è durata il tempo di qualche mese, prima che le condizioni di lavoro degli infermieri negli ospedali e, in particolare, nei pronto soccorso, tornassero a contare poco, tra burnout, aggressioni e tagli del personale. Perché, si dice, «l’infermiere è pagato anche per questo».
La vita degli infermieri nei pronto soccorso
La storia dei pronto soccorso italiani è una storia di tagli a fondi e personale che va avanti dal 2008. Ma è anche una storia di promesse da campagna elettorale, che si intreccia con la vita dei lavoratori e dei pazienti. Barbara, ad esempio, lavora al triage di un ospedale della Toscana, una Regione che dovrebbe rappresentare un’eccellenza nella sanità pubblica. Eppure, a causa della mancanza di personale, Barbara è stata sbattuta in prima linea al pronto soccorso appena entrata in ospedale. «Già il secondo giorno di lavoro sono stata messa ai codici rossi, in emergenza, senza nessun tipo di esperienza, quando in realtà sarebbero previsti almeno sei mesi di affiancamento da parte di un collega più esperto», racconta. «È una pratica molto pericolosa, sia per noi che per i pazienti». Con l’adozione dei contratti interinali, poi, ogni mese gli infermieri cambiano. «Con il numero di accessi che ci sono in pronto soccorso è impensabile che possa esserci un professionista preposto alla formazione dei nuovi arrivati, sapendo che il mese dopo non ci sarà più. Quindi non si fa formazione, ed è molto rischioso», spiega.
Ma lavoro interinale e mancata formazione sul posto di lavoro non sono le sole criticità con cui un infermiere deve confrontarsi. Roberta è un’infermiera genovese con 30 anni di esperienza alle spalle e che conosce molto bene che cosa sia il demansionamento a cui è andata incontro la professione infermieristica. «Siamo degli sguatteri: ci manca solo che mi diano un pennello in mano e mi chiedano di dare il bianco», dice a VD. «Con il demansionamento perdiamo il riconoscimento sociale dell’utente: se il paziente mi vede camminare con i sacchi neri dell’immondizia, mi tratta come un facchino. Il tutto per 1.400 euro al mese. Il titolo universitario, però, ce lo siamo guadagnato noi infermieri». Le mansioni domestico-alberghiere dovrebbero infatti spettare alla figura dell’operatore socio-sanitario.
Ma molte strutture preferiscono risparmiare sulle nuove assunzioni e ricorrere agli infermieri che, però, in questo modo, hanno meno tempo da dedicare al paziente. «Dobbiamo sapere fare tutto: dal rianimare, al preparare le terapie, all’imboccare i pazienti, al pulire i pappagalli. Dateci invece la possibilità di fare gli infermieri. Alla fine ti senti umiliato e degradato. E poi, però, ti incazzi come una biscia», spiega Roberta. «“Signorina mi gira il cuscino? Mi apre la finestra? Mi accende la televisione?“, ti dicono. Le persone non pensano che non puoi rovistare nella merda e poi tornare a preparare la terapia endovenosa. Le mansioni domestiche alberghiere sono compito dell’operatore socio sanitario. Non è l’infermiere che se ne deve occupare, così come non se ne può occupare il medico. Ci sono competenze che non è bene mescolare». E con delle responsabilità legali notevoli, paragonabili a quelle dei medici, nonostante il rapporto economico sia sbilanciato a favore dei secondi. «Lavorare come infermiere è troppo faticoso e il ritorno economico non vale lo sforzo», dice Barbara. «Un medico che fa le nostre stesse ore prende 3.500 euro. Noi, invece, prendiamo quanto un non laureato».
Infermieri in fuga, tra burnout e aggressioni
Secondo Andrea Bottega del sindacato Nursind, sul mercato del lavoro mancano circa 63 mila infermieri. «Stando ai dati OCSE, per 1000 cittadini ci dovrebbero essere 8,8 infermieri. In Italia, invece, ce ne sono 6,2. La Germania ne ha 13,9: sotto di noi ci sono Polonia e Grecia», spiega. Dopo l’emergenza Covid, sono tanti gli infermieri che hanno deciso di licenziarsi, a cui si aggiungono i professionisti non vaccinati sospesi dall’Ordine. «Siamo invecchiati di dieci anni in questi mesi. Ci hanno mandato ad affrontare il virus con la mascherina antipolvere», dice Bottega. «Mettono gli interinali in pronto soccorso perché in pronto soccorso non ci vuole venire più nessuno. E il turnover di uscita è molto più alto rispetto a quello di entrata: dopo anni passati in trincea è dura voler continuare a fare questo lavoro», continua Claudio Cullurà, segretario territoriale di Nursind. E così, tra aggressioni e turni massacranti, i pronto soccorso si svuotano di infermieri. C’è poi un altro fattore che rende poco appetibile la professione infermieristica. «Si fa fatica a trovare persone che vogliano fare questa professione. Il riconoscimento economico fatica a far decollare una professione che si sacrifica, si carica di responsabilità e mantiene in piedi il sistema sanitario nazionale», dice Stefano Barone di Nursind.
Ed è il sacrificio a essere diventato parte integrante della vita degli infermieri, tra aggressioni e burnout, che non viene riconosciuta come malattia professionale. Fenomeni che interessano i grandi ospedali come i piccoli. «Ho una collega di 63 anni che lavora al pronto soccorso e al 118, perché l’azienda non la trasferisce in un servizio più leggero», racconta Andrea, che fa l’infermiere in un ospedale umbro. «Sta male, non ce la fa più. E così si imbottisce di benzodiazepine. In fondo, siamo solo numeri che devono riempire una casella». «Arrivo a casa da lavoro e ho tutto questo carico di tristezza, perché vedo la gente morire», dice Roberta. «A un certo momento della tua carriera, capita di incontrare un paziente che ti metta al posto di Dio. Ed è scomodo stare al posto di Dio. Ti guardano con gli occhi supplicanti e non sempre riesci a salvarli, perché nell’ordine naturale delle cose c’è la morte. Me li ricordo tutti quelli che mi sono morti, ognuno è una piccola cicatrice e per quanto tu possa sembrare cinico, ti porti tutto a casa».
Il Pronto Soccorso è in crisi
Con la popolazione che invecchia, lo smantellamento degli altri presidi territoriali e la riduzione del personale, i tempi di attesa nei pronto soccorso crescono esponenzialmente. E a fare da parafulmine c’è il personale infermieristico, composto per la maggior parte da donne che si trovano a doversi difendere da parenti e pazienti inferociti per le lunghe attese. «Le persone ci aggrediscono e nessuno ci difende. Le direzioni se ne fregano», racconta Roberta. «Nel frattempo, però, ci fanno i corsi per contrastare la violenza sugli operatori: ti dicono che devi disinnescare la violenza ma se prendi un pugno in faccia, non ce l’hai il tempo di provare a sedare l’atteggiamento violento. Ci viene anche detto di metterci di profilo quando arriva il pugno, perché così offriamo meno superficie da colpire, e di frapporre un oggetto tra noi e la persona che ci aggredisce. Peccato che nel mentre che si fanno tutte queste operazioni, si rischi di finire per avere due ossa fratturate. Ma se reagiamo abbiamo torto noi e finiamo in consiglio di disciplina». Barbara, invece, è stata aggredita qualche mese fa. «Un paziente mi ha presa a calci e mi ha schiaffeggiata», dice. «È un fenomeno che è esploso a causa delle lunghe attese. I familiari, poi, a causa dell’emergenza Covid, non possono più entrare con il paziente e accertarsi di persona del suo stato di salute. Certo, anche da parte nostra capita di buttare benzina sul fuoco. Siamo stanchi: pensi di fare il massimo con gli strumenti che hai ma vieni aggredito».
«Siamo massacrati da utenza e dirigenza», spiega ancora Roberta. «Sono tutti buoni a riempirsi la bocca di malasanità, ma dovrebbero venire a vedere perché succedono queste cose: in un reparto eravamo un infermiere ogni 13 pazienti. Dovevo tirare la monetina per capire chi salvare. E alla fine ti chiedi se hai fatto la scelta giusta a fare il massaggio cardiaco a un paziente piuttosto che a un altro»: una chiusa perfetta per la parabola degli eroi contro il Covid.
Segui VD su Instagram